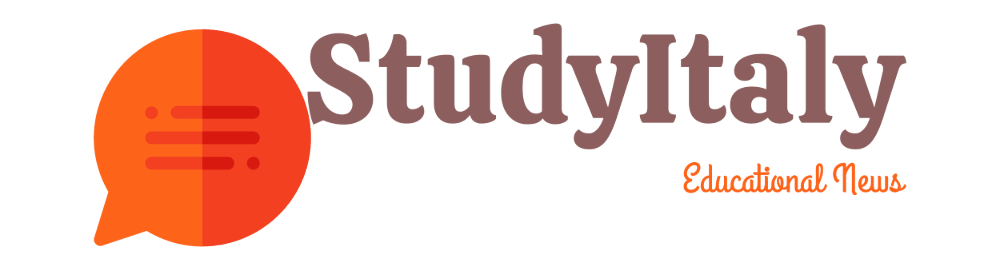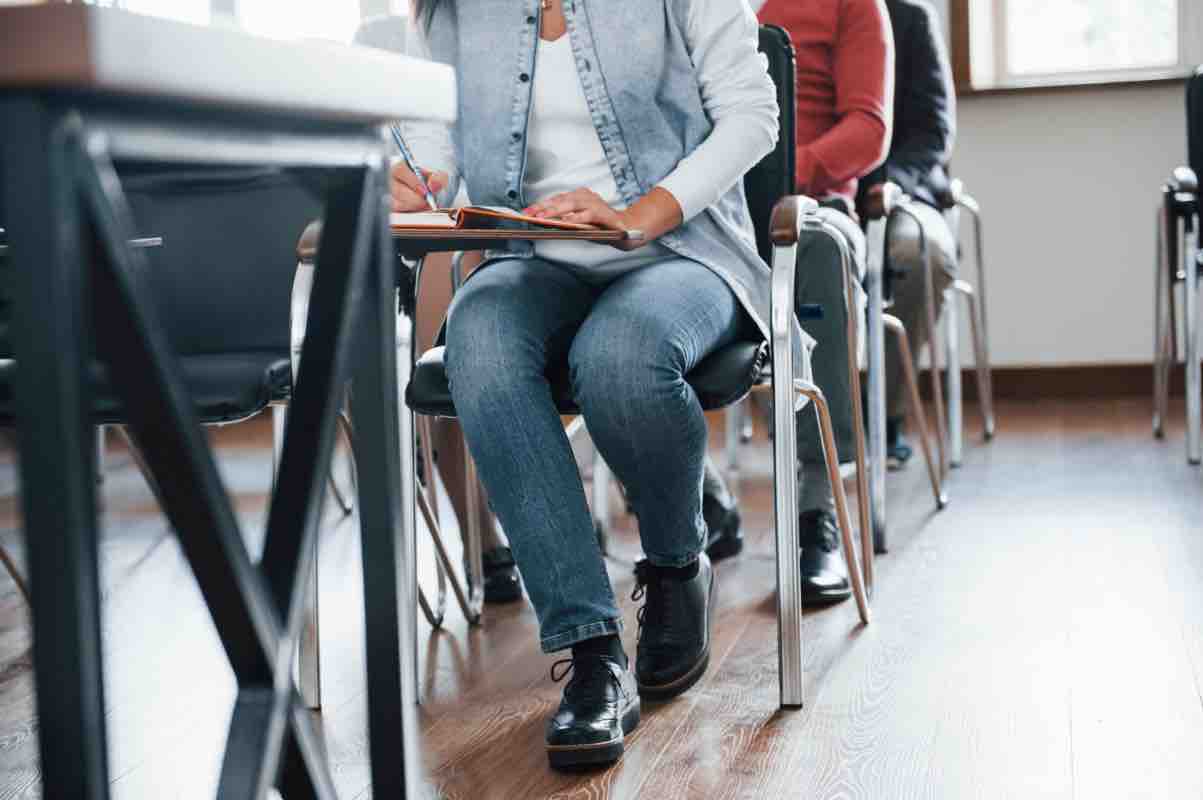Dai mega atenei ai politecnici, il Censis 2025 rivela quali università italiane offrono le migliori opportunità di lavoro ai propri laureati.
Scegliere l’università, oggi, non significa solo decidere cosa studiare, ma anche dove investire per avere un futuro lavorativo reale. Per molti studenti e famiglie, la domanda non è più soltanto accademica: “Dove troverò lavoro dopo la laurea?”.
È una scelta che pesa, che influenza anni di vita e sacrifici economici. Perché in Italia, lo sappiamo, una laurea non basta più. Serve un’università capace di connettere la formazione con il mondo reale, e non solo con le aule.
Come il Censis misura l’occupabilità
Ogni anno il Censis pubblica una classifica delle università italiane basata su sei indicatori: didattica, strutture, servizi, borse di studio, internazionalizzazione e occupabilità. Quest’ultimo dato è forse il più concreto, perché misura quante possibilità reali hanno i laureati di trovare lavoro dopo il titolo. I numeri provengono da AlmaLaurea, il consorzio che monitora l’inserimento lavorativo dei laureati a uno, tre o cinque anni dalla laurea.

Il Censis rielabora questi dati e assegna a ogni università un punteggio su 110, valutando non solo la percentuale di occupati, ma anche la rapidità d’inserimento, la tipologia contrattuale e l’adeguatezza del lavoro rispetto al titolo di studio. In questo modo, il punteggio finale restituisce un quadro più realistico: non solo chi lavora, ma anche quanto bene e quanto presto.
Non si tratta di un indicatore perfetto, ma è uno dei pochi che permette di capire quali atenei offrono davvero un ponte verso il mondo del lavoro. Alcune università investono su percorsi di orientamento, tirocini e contatti diretti con le aziende, altre invece restano più distaccate dalla realtà professionale. E la differenza, come dimostrano i dati, si vede.
I mega atenei: Milano e Pisa in vetta alla classifica
Tra i mega atenei statali, quelli con oltre 40.000 iscritti, emergono i nomi più noti ma anche più competitivi sul piano dell’occupazione. In testa alla classifica 2025/2026 ci sono Milano e Pisa, entrambe con 97 punti, seguite da Padova (94), Firenze (93) e Bologna (92). Più indietro, ma comunque solidi, Torino (91), La Sapienza di Roma (89), Federico II di Napoli (85), Bari (77) e Palermo (73).
Il dato è chiaro: il Centro-Nord domina in termini di occupabilità. Questi atenei beneficiano della vicinanza con distretti industriali, start-up e realtà imprenditoriali dinamiche. A Milano, per esempio, il contatto con le aziende è diretto: laboratori, stage e partnership facilitano l’ingresso nel mercato del lavoro. Al Sud, invece, il potenziale formativo è alto, ma la mancanza di un tessuto produttivo forte rallenta la transizione post-laurea.
Chi sceglie un mega ateneo del Nord parte con un vantaggio competitivo. Ma deve anche saperlo sfruttare, perché in università così grandi la concorrenza è elevata e serve determinazione per distinguersi.
I grandi atenei: Modena e Reggio Emilia guidano il gruppo
Nella fascia intermedia, con 20.000–40.000 iscritti, i grandi atenei offrono un equilibrio tra strutture organizzate e rapporti più diretti con il territorio. In vetta alla classifica 2025/2026 troviamo l’Università di Modena e Reggio Emilia (104 punti), seguita da Milano Bicocca (103), Ferrara (101), Verona (101) e Genova (99).
Questi risultati dimostrano come la dimensione media-grande possa essere un vantaggio. Modena, ad esempio, lavora da anni su un modello di placement efficace, che unisce tirocini, collaborazione con imprese e orientamento attivo. Bene anche Ferrara e Verona, dove le iniziative di contatto con le aziende sono ormai parte integrante dei corsi di laurea.
In fondo alla classifica troviamo atenei come Messina, Calabria e Chieti-Pescara, penalizzati più dal contesto territoriale che dalla qualità didattica. Dove mancano opportunità lavorative locali, anche i percorsi più validi faticano a tradursi in occupazione concreta.
I medi atenei: il caso virtuoso di Ancona
Tra i medi atenei, con 10.000–20.000 iscritti, spicca la Politecnica delle Marche (106 punti), seguita da Brescia e Insubria (104), Bergamo e Piemonte Orientale (103). Qui la chiave è il legame diretto con il tessuto produttivo. Ancona, in particolare, è un esempio virtuoso: la collaborazione costante con le imprese del territorio, soprattutto nei campi dell’ingegneria e della sanità, consente a molti studenti di trovare lavoro già pochi mesi dopo la laurea.
Molto bene anche Trento e Trieste, storicamente solide, mentre le università del Sud come Salento e Napoli L’Orientalerestano indietro, non per mancanza di qualità accademica, ma per scarse connessioni con il mercato del lavoro. In questo segmento, la prossimità territoriale e la rete con le aziende fanno la vera differenza.
I piccoli atenei e i Politecnici: due mondi opposti
I piccoli atenei offrono spesso ambienti familiari e relazioni più dirette, ma faticano a garantire sbocchi lavorativi solidi. In testa Camerino (96 punti), seguita da Tuscia (84) e Basilicata (83). In questi contesti, la vicinanza tra docenti e studenti aiuta la formazione personalizzata, ma la mancanza di grandi imprese limita le opportunità.
Al polo opposto, i Politecnici confermano la loro superiorità assoluta in termini di occupabilità:
Politecnico di Milano → 110
Politecnico di Torino → 110
Politecnico di Bari → 109
Iuav di Venezia → 97
Qui il legame con il lavoro è parte integrante della formazione. Le collaborazioni con le aziende, le start-up e i centri di ricerca fanno sì che molti laureati trovino impiego entro poche settimane dal titolo.
Studiare va bene. Ma poi, si lavora?
Dai dati del Censis 2025/2026 emerge un quadro nitido: studiare non basta più, serve un’università che accompagni davvero verso il lavoro. Le differenze territoriali restano forti, ma la tendenza è chiara: dove c’è innovazione, rete e visione concreta, l’università diventa un ponte, non un vicolo cieco.
Per chi oggi sceglie dove studiare, l’indicatore sull’occupabilità non è una risposta definitiva, ma una bussola indispensabile. Perché studiare è un diritto, ma trasformare lo studio in autonomia economica dovrebbe esserlo ancora di più.